Tunisia vs Resto del Mondo 1-0 (ma siamo al 5’ del primo tempo)
Dimostrazioni, tafferugli, tumulti. Una semplice manifestazione di scontento. Sono assiepati di fronte alla Prefettura di Sidi Bouzid, una piccola città della Tunisia interna, un posto dove nessuno va per turismo o per curiosità. Protestano perché a Mohamed Bouazizi, un ragazzo di 26 anni, la polizia ha sequestrato il banchetto di frutta e legumi. Mohamed è laureato in letteratura, uno che ci ha provato e come tanti in Tunisia non è riuscito a trovare un posto. Tira avanti, nella sua città d’origine, facendo la corsa a ostacoli. È disperato, però, e allora compie un gesto sproporzionato: si dà fuoco e la città si infiamma. La gente scende in strada per protestare.
È il 17 dicembre e nessuno pensa che questo evento possa avere qualche conseguenza su scala nazionale. Negli ultimi anni in Tunisia si sono registrate manifestazioni, anche violente, ma tutte circoscritte, tutte legate a un evento locale. Tutte sedate senza che la comunità internazionale ne ricevesse anche solo l’eco.
La Tunisia è un paese relativamente libero, tutti pensano. Fra i paesi del Maghreb è il paese che sta meglio, se prendiamo come parametro il PIL o il reddito pro-capite.
La libertà della Tunisia, invece, è una finzione. È uno Stato di polizia, corrotto, retto da un tiranno e dai suoi sodali. Le televisioni non informano, la rete viene costantemente monitorata dalle autorità. I giornalisti vanno in galera. Le denuncie delle associazioni per i diritti umani e per la libertà di espressione non producono attenzione nei media internazionali, perché attorno a sé la Tunisia ha paesi meno liberi, meno ricchi, ed è come se avere meno problemi significhi non averne affatto.
È per questo che a livello internazionale passa sotto silenzio l’ondata di rivelazioni di Wikileaks sul paese. I diplomatici americani descrivono la Tunisia come una repubblica delle banane, il suo leader è un bandito, i suoi amici fanno il bello e il cattivo tempo. I tunisini, invece, vedono in quelle rivelazioni uno spiraglio. Non sono i soli a sapere ciò che succede nel loro paese, nelle ambasciate circolano le informazioni, e ora ci sono documenti che lo provano.
A Sidi Bouzid la protesta non si ferma. Mohamed è in ospedale, in fin di vita. Scendono in strada in tanti, con i volti coperti, quasi tutti giovani o giovanissimi. Lanciano pietre, hanno bastoni, non hanno paura, sembra. Affrontano le camionette della polizia quasi per inerzia. La protesta varca i confini della città, si estende a macchia d’olio. In una decina di giorni sono almeno venti i centri in cui si registrano ribellioni. La scena è la stessa ovunque: si raccolgono attorno alle sedi del sindacato, protestano di fronte alle prefetture, di fronte alle stazioni di polizia. Distruggono, a volte, quello che si trovano davanti, e a volte saccheggiano. Gli avvocati escono dai tribunali, con i loro abiti d’ordinanza, protestano anche loro. Ma nessuno, fuori dalla Tunisia, pensa che valga la pena darne notizia. Sembrano cose piccole, circoscritte, niente di più normale, niente per cui valga la pena scrivere una riga.
Invece è una rivolta, un’insurrezione, dilaga in centri grandi e piccoli, corre verso nord, dove ci sono le attività produttive, arriva sulla costa, nelle città portuali, fino ad affacciarsi a Tunisi, prima in forma di flash mob, poi in forma di dimostrazione di piazza. È il 27 dicembre, e la polizia impedisce a un migliaio di disoccupati di imboccare Avenue Habib Bourguiba, l’ampio viale alberato che chiunque sia stato a Tunisi non può non aver percorso almeno una volta.
Ben Ali, il Presidente, inizia a sentirsi a disagio. Visita l’ospedale dove Mohamed Bouazizi è ricoverato. Il suo sorriso liftato non ha alcun impatto, anzi provoca maggiore astio se messo accanto all’immagine di un uomo fasciato dalla testa ai piedi che non riesce neanche a parlare.
Il dittatore invita alla calma, promette posti di lavoro e prezzi più bassi, ma non serve a niente, la gente non lo ascolta più o meglio: non lo ha mai ascoltato davvero e tanto meno adesso.
Scendono in campo gli hackers di Anonymous. Bloccano per prima cosa i siti della Borsa e del Ministero degli esteri: voi chiudete la rete ai tunisini, noi chiudiamo voi. E intanto si contano i morti. Due, cinque. Le informazioni sono confuse, disturbate. Ma una cosa si sa. La maggior parte delle vittime si è suicidata. Sono tutti giovani, si sono dati fuoco, come Mohamed Bouazizi, uno di loro si è lanciato contro i fili dell’alta tensione, è morto fulminato. Si suicidano per testimoniare la disperazione, è come se dicessero agli altri di non aver paura: se uno si è immolato altri cento, altri mille possono scendere in strada, senza più freno, senza più riguardo per la propria incolumità.
Ma ancora nessuno, fuori, parla di tutto questo, fino a quando scoppiano i tumulti in Algeria. Lì la cosa è un po’ diversa. Nessuno lì si suicida, o meglio: il suicidio dei giovani in Algeria è purtroppo già routine e l’atto, finora, non ha spinto altri alla rivolta. Escono dai sobborghi delle città e saccheggiano, incendiano, le autorità reprimono con forza, uccidono. È meno difficile leggere l’Algeria, almeno da parte dei media internazionali, e solo adesso le televisioni e i giornali di tutto il mondo accendono i riflettori su quella cosa a cui viene dato il nome di “rivolta del pane”.
Piovono analisi: i prezzi salgono alle stelle, le speculazioni finanziarie globali, il rischio – si dice – che il malcontento si estenda al resto del Maghreb e oltre, in altre aree depresse del mondo. Fa di nuovo capolino la minaccia islamista, l’argomento su cui Ben Ali, Bouteflika, Mohammed VI, Mubarak hanno giustificato la loro occupazione del potere negli ultimi venti anni.
Però la gente questa volta non esce dalle moschee, come succedeva negli anni ’90 ad Algeri. Sono giovani, il terrorismo l’hanno subito due volte, con le bombe degli islamisti e con la repressione dei dittatori. Non hanno voglia di ascoltare i sermoni patinati di qualche “purissimo” barbuto su youtube friendly, non gli interessa fare i kamikaze: voglio vivere liberi nel loro paese. Hanno gli strumenti, le capacità, e saprebbero cosa fare se avessero la possibilità di fare.
Siamo all’inizio del 2011 e in Tunisia, dopo i moti di Redeyef nel 2008 – durati diversi mesi ma rimasti circoscritti al bacino minerario di Gabes – e le proteste dell’agosto 2010 con epicentro a Ben Gardane, una cittadina alla frontiera con la Libia – che si chiusero con un arretramento delle pretese del regime di fermare i traffici di merci a buon mercato da quel paese – c’è una rivolta. È intitolata alla città di Sidi Bouzid ma è ormai di rilievo nazionale e inizia a trasformarsi, a organizzarsi in una rivoluzione. Lo vedi sui social network, lo leggi sui circuiti dei bloggers ma sulla stampa di carta e di pixel non vedi niente: le cronache dalla Tunisia rimangono sullo sfondo. A nulla servono i comunicati delle associazioni, dei gruppi di cittadini, degli studenti, dei sindacalisti, degli avvocati.
Nel resto del mondo passa l’idea che è per il pane, non per la libertà, che questa gente scende in piazza. Dategli il pane e loro ritorneranno a casa, questa è la headline, così rassicurante, così facile, così distante da noi, che il pane ce l’abbiamo.
Invece il pane non basta. I tunisini la rivolta del pane l’hanno già fatta, e l’hanno vinta, fra il 1983 e il 1984, quando l’allora presidente (e “padre della patria”) Habib Bourguiba, fece rientrare tutto con un messaggio in televisione e con l’immissione di derrate alimentari per la popolazione. Adesso è un’altra cosa: non vogliono più Ben Ali, non vogliono più gli sgherri del suo partito (RCD, Rassemblement Constitutionnel Démocratique), non vogliono più vedere sua moglie e la sua famiglia saccheggiare la Tunisia, sono stanchi di pagare il pizzo ai poliziotti, di vivere sotto ricatto, vogliono indietro il loro paese.
Ben Ali, in televisione e alla radio, gioca la carta del nemico esterno. Ma nessuno sa chi sia questo nemico di cui parla il mezzobusto, nessuno li ha visti, i terroristi. È un vecchio giochetto che usava al tempo del colpo di Stato del 1987, quando con la complicità dei servizi segreti italiani, salì al potere (sì, Craxi era Primo ministro. Sì, Andreotti era Ministro degli esteri. Sì, nel 1994 Craxi scappò a Hammamet dal suo amico Ben Ali). Intanto gli amici di sempre si fanno avanti senza timore. In Francia la Ministra degli Esteri offre “appoggio tecnico” al Governo – che significa inviare truppe speciali – in puro stile coloniale. In Italia Franco Frattini “appoggia il Governo tunisino”, agitando – come un disco rotto – lo spauracchio del terrorismo islamico. Tutti gli altri tacciono, o reagiscono poco. Alla spicciolata l’Unione Europea o l’ONU, con formulazioni tanto rituali quanto intempestive e sottodimensionate, “condannano le violenze”.
Il 4 gennaio Mohamed Bouazizi muore nel suo letto d’ospedale e la rivolta raggiunge stabilmente Tunisi: non si patteggia più. L’esercito scende in campo, c’è il coprifuoco, è una rivoluzione, ma per il mondo è ancora quella “rivolta del pane” che in Algeria è stata ormai sedata: ci vorrà del tempo e del coraggio prima di rivedere qualcuno in piazza ad Algeri.Girano voci di un possibile golpe e con esse si fanno avanti i complottisti. Possiamo classificarli in due categorie: i post-moderni da salotto – i fanatici della fine della storia per cui “tutto è già stato scritto” – e gli amanti della letteratura spionistica – quelli che il Mossad l’aveva detto, quelli che il battito di farfalla in Cina.
Golpe mascherato, dicono. C’è un accordo con Obama. Ma da un bel po’. Girano foto in cui, da casa, gli spettatori si dovrebbero chiedere chi siano quei tunisini in pettorina durante la manifestazione: cospiratori? Militari in borghese? In pochi notano che l’esercito in Tunisia è sì una forza in campo, ma anche una forza debole: Ben Ali ha privilegiato la polizia, la guardia presidenziale, come si legge in qualsiasi manuale per tiranni. Il rapporto è di 1 a 4. Un militare per quattro poliziotti. E poi nessuno sa cosa faranno davvero i militari, neanche in Tunisia, tanto che nasce la proposta di “mettere fiori nei loro fucili”, in particolare gelsomini. Ma il dibattito si ferma lì: non serve mettere niente nei fucili dei militari perché l’esercito si ritira senza sparare un colpo.
Ben Ali prova la stretta repressiva. A Tunisi la protesta viene soffocata pesantemente dai poliziotti, gli avvocati vengono presi a bastonate, mentre a Qasserine, nel centro del paese, si consumano gli scontri più sanguinosi, oltre 50 morti. Ma la rivoluzione non si ferma e il regime si scopre al capolinea. Il 13 gennaio, il giorno prima dello sciopero generale di Tunisi, Ben Ali riappare in TV per dire che darà tutto ciò che la gente chiede: democrazia, occupazione, libertà di stampa e di associazione. Lascerà il potere nel 2014, dice. Chiede alla polizia di non usare la forza se non per difendersi ma proprio in quelle ore dai social network arriva la notizia che nelle dimostrazioni entrano in azione gli infiltrati, che distruggono tutto e danno l’alibi ai poliziotti per attaccare gli inermi.
È l’ennesimo bluff, ed è comunque troppo tardi per giocarlo. Già da qualche giorno girano le facce dell’opposizione democratica, l’alternativa “accettabile” al tiranno. È il 14 gennaio e Ben Ali si dà alla fuga. Forse è a Malta, forse è in Italia, forse in Francia. Sembra che non lo voglia nessuno e alla fine se lo prende l’Arabia Saudita, il rifugio dei tiranni. Lui, il campione della laicità nel mondo arabo, si va a nascondere nel paese più confessionale e retrogrado del mondo: il vero volto dell’autocrate è svelato.
In Tunisia è il giorno della vittoria. La bandiera nazionale, la piazza. La Tunisia è nelle mani dei manifestanti che abbattono i simboli, tolgono le effigi del dittatore dai luoghi pubblici, dai negozi. Le residenze del Re e della Regina vengono prese d’assalto. Ora tutti, nel mondo, la chiamano “rivoluzione del gelsomino”, ma questa, semplicemente, è diventata la prima rivoluzione tunisina.
Le cose si dispongono in un ordine, anche se precario: l’esercito è dalla parte degli insorti, lì protegge. Dall’altra parte ciò che rimane del regime – i fedelissimi del partito, i suoi sicari, molti poliziotti – scatena la propria rabbia, mettendo a ferro e fuoco le sedi dei partiti d’opposizione, saccheggiando quello che si può, cercando – in vano – di provocare il caos. I più prezzolati scappano col bottino, le seconde file girano in pick-up e fanno razzie, mentre la gente organizza ronde, posti di blocco, autodifesa.
Giorni di apnea in Tunisia. Nasce un governo provvisorio dal quale escono immediatamente tutti i rappresentanti delle opposizioni. La gente scende ancora in piazza, stavolta con più fiducia: vogliono che l’RCD sia dichiarato fuorilegge, vogliono chiudere la partita. E le cose sembrano andare sempre meglio.
In giro per il mondo, invece, sono giorni di paura. Paura per i dittatori dei paesi vicini che vedono crescere il dissenso, in forme che ricordano i primi vagiti della rivoluzione tunisina. Paura per tutti i partiti e le associazioni islamiste che avevano fatto fortuna col motto (coniato dai Fratelli Musulmani) “l’islam è la soluzione” e avevano vivacchiato sotto i regimi autoritari, talvolta colludendo con essi. L’islam non è la soluzione. O perlomeno non lo è stata in Tunisia, l’unico posto nel mondo arabo in cui qualcosa è successo, in cui una speranza si è accesa. Così come la soluzione non è lasciare al potere i tiranni, e permettere che a loro succedano altri tiranni. Hanno sbagliato tutti, in Europa, in Occidente. Tremano i fautori del conflitto di civiltà, i terroristi, i neocon, i fondamentalisti di Oriente e Occidente: il loro racconto si è dissolto perché non è sull’asse delle civiltà che ha ripreso a camminare la storia. Tornano le parole giuste: dittatura, regime. La categoria “paesi islamici moderati” è disintegrata, non compare più da nessuna parte. Almeno per ora. Perché sì, la Tunisia insegna, ma Moody’s – senza por tempo in mezzo – declassa la Tunisia. E se quella tunisina è una rivoluzione laica, sono in tanti a volerla convertire in “qualcosa di islamico”. Affinché tutto rimanga esattamente come è stato fino al 17 dicembre.
https://in30secondi.altervista.org/2011/03/15/tunisia-vs-resto-del-mondo-1-0-ma-siamo-al-5-del-primo-tempo/In fiammeLoop,Prequel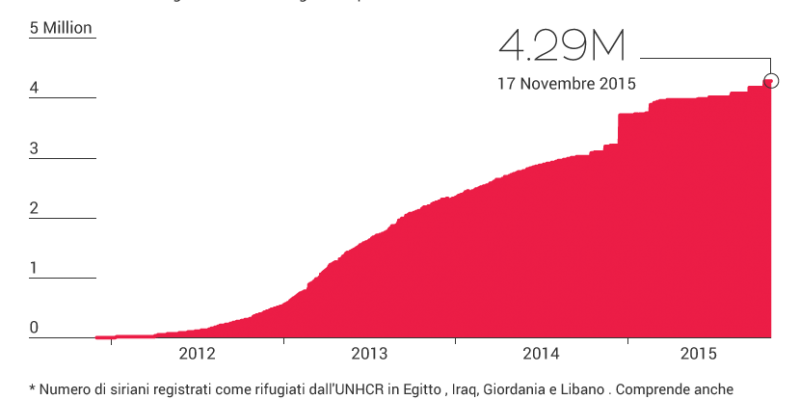
Lascia un commento